INTRODUZIONE
I. «Nulla insegna quanto il tradurre»
Verso il principio dell'anno '76, trovandomi già da sei e più
mesi ingolfato negli studi italiani, mi nacque una onesta e cocente vergogna
di non più intendere quasi affatto il latino; a segno che, trovando
qua e là, come accade, delle citazioni, anco le più brevi
e comuni, mi trovava costretto di saltarle a piè pari, per non perder
tempo a diciferarle. Trovandomi inoltre inibita ogni lettura francese, ridotto
al solo italiano, io mi vedeva affatto privo d'ogni soccorso per la lettura
teatrale. Questa ragione, aggiuntasi al rossore, mi sforzò ad intraprendere
questa seconda fatica, per poter leggere le tragedie di Seneca, [...] e
[...] le traduzioni letterali latine dei tragici greci [...]. Mi presi dunque
pazientemente un ottimo pedagogo, il quale, postomi Fedro in mano con molta
sorpresa sua e rossore mio, vide e mi disse che non l'intendeva [...]. Ma
il valente pedagogo, avuto ch'egli ebbe così ad un tempo stesso il
non dubbio saggio e della mia asinità, e della mia tenacissima risoluzione,
m'incoraggì molto, e in vece di lasciarmi il Fedro mi diede l'Orazio,
dicendomi: «Dal difficile si viene al facile; così sarà
cosa più degna di lei».
Così Alfieri, ventisettenne, affronta, con la determinazione che
gli è propria, la necessità di dovere del tutto rifondare
la sua conoscenza del latino. Il cimento con l'Orazio delle Odi,
impostogli dall'insegnante, si rivela adatto a stimolare lo scrittore, così
«rimesso in grammatica senza [...] uscire di poesia»,
e ad avviare l'inesausto esercizio del tradurre che, di qui in poi l'accompagnerà
per tutta la vita.
Già pochi mesi dopo, in primavera, a Pisa, agli si misura con altre
prove: la traduzione in prosa della Poetica di Orazio «per
inversarsi que' suoi veridici e ingegnosi precetti», la lettura
delle tragedie di Seneca - constatando quanto esse fossero «il contrario»
degli insegnamenti oraziani -, e di altri scrittori «ad oncia a oncia»,
tra i quali, e soprattutto, Sallustio. L'autore della Catilinaria
e della Giugurtina è quindi il primo dei grandi è
quindi il primo dei grandi storici latini ad attrarre Alfieri ed è
anche quello destinato a occupare un posto preminente su tutti gli altri.
Le successive letture di Livio e di Tacito, che pure gli porgeranno spunti
e materiali per il trattato Della Tirannide e la Virginia,
non stimoleranno l'Alfieri traduttore a intraprendere un'impresa paragonabile
a quella del suo Sallustio, fatto oggetto di un vincolo diuturno quanto
tormentato.
[..] |
INDICE
PRESENTAZIONE
INTRODUZIONE
NOTA AI TESTI
LA GUERRA DI CATILINA
SECONDO IL MANOSCRITTO LAURENZIANO
LA GUERRA DI CATILINA
SECONDO IL MANOSCRITTO LAURENZIANO
BELLUM CATILINARIUM
SECONDO IL MANOSCRITTO LAURENZIANO
LA GUERRA DI GIUGURTA
SECONDO IL MANOSCRITTO LAURENZIANO
LA GUERRA DI GIUGURTA
SECONDO IL MANOSCRITTO LAURENZIANO
BELLUM IUGURTHINUM
SECONDO IL MANOSCRITTO LAURENZIANO |
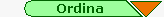
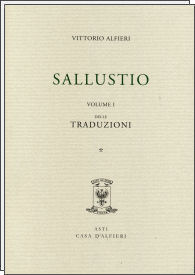
Vittorio Alfieri
SALLUSTIO volume I - traduzioni
editore CASA D'ALFIERI
edizione 2005
pagine 1344
formato 18x25
2 volumi in cofanetto; brossura con sovracoperta
tempo medio evasione ordine
a richiesta
60.00 €
60.00 €
ISBN :
EAN :
|
|